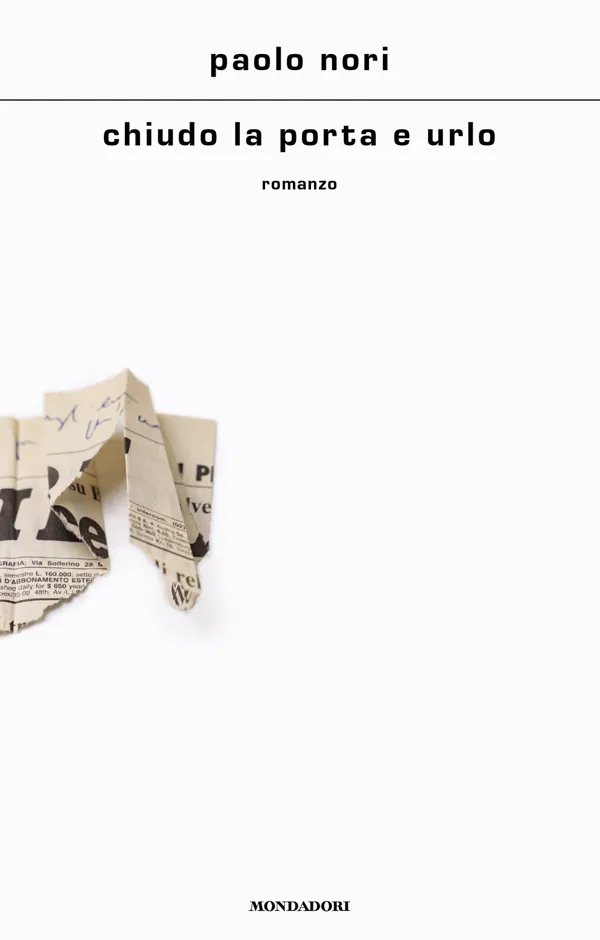
Paolo Nori, chiudo la porta e urlo, Mondadori
"Che io, vorrei chiarire, non sono contrario alla grammatica, e alle grammatiche, mi piacciono molto, mi piacciono talmente che ho studiato non solo quella dell’italiano, anche quella del francese, e del russo, ho fatto anche sette esami di filologia, descrivo solo una condizione che ha fatto sì che per decenni la lingua scritta e la lingua parlata, in Italia, fossero come due territori distinti, uno da una parte e l’altro dall’altra, e la cosa che a me sembra incredibile è che noi, che parliamo italiano oggi, nel 2023, siamo tra i primi a trovarci in una situazione dove questa divaricazione, questa distinzione, è quasi caduta, noi ci capiamo tutti gli uni con gli altri, e il fatto che i nostri accenti, le nostre sintassi, l’ordine delle parole nelle nostre frasi, indichino, abbastanza chiaramente, di solito, da che parte d’Italia veniamo, a me non sembra un difetto ma un pregio, della nostra lingua (…)" (p. 61)
Il romanzo di Paolo Nori è un viaggio nella poesia di Raffaello Baldini e della doppia anima delle sue poesie scritte nel suo dialetto di Sant’Arcangelo di Romagna e da lui stesso tradotte in italiano, una ricerca filologica che si riflette nel ritmo e nelle cadenze del romanzo stesso.